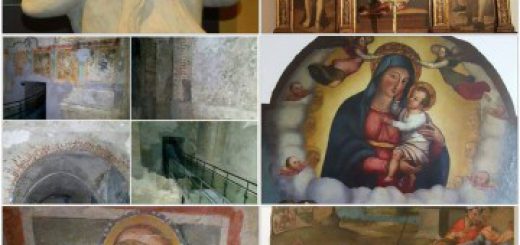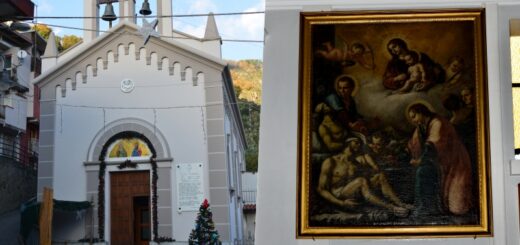LE VILLE VESUVIANE DI BARRA
MARIO COLANGELO – DELEGAZIONE RAM BENEVENTO
Tra le opere architettoniche in assoluto più interessanti della Campania si segnalano le ville vesuviane che si snodano da San Giovanni a Teduccio a Torre del Greco, passando per Barra, San Giorgio a Cremano, Portici ed Ercolano. Tali edifici testimoniano una fase storico-artistica ben precisa che si colloca tra la metà del Settecento e la prima metà dell’Ottocento, anche se non mancano edifici secenteschi o tardo-ottocenteschi. La realizzazione di questi complessi monumentali è legata alla presenza di un fulcro ben preciso, la Reggia di Portici, una delle residenze borboniche più importanti (e anche tra le più amate dai sovrani), costruita tra il 1738 e il 1742, ma poi rimaneggiata in epoca murattiana secondo lo stile neoclassico.
Attorno al palazzo reale e ad altri siti borbonici annessi, quali Villa d’Elbeouf a Portici e Villa Favorita ad Ercolano, i nobili del regno si fanno costruire le loro ville, spesso di qualità eccelsa ed affidate ad architetti di grido come Ferdinando Sanfelice, Domenico Antonio Vaccaro, Antonio Canevari, Giovanni Antonio Medrano, Ferdinando Fuga, Luigi Vanvitelli, Carlo Vanvitelli, Mario Gioffredo, Pompeo Schiantarelli, o a decoratori molto in voga, tra cui Gaetano Magri, Fedele Fischetti, Giacomo Del Po, Giuseppe Bonito, Crescenzo La Gamba, Vincenzo Re.
Queste ville, il cui stile varia da un elegante e raffinato tardo-barocco a un neoclassicismo leggero e riposante, sono in particolar modo contraddistinte dal giardino che fa loro da corona, giardino che si suddivide in due sottoclassi principali, entrambe unite dalla casistica del punto di fuga che parte da un portale, avanza per l’atrio e l’androne, viene pio convogliato tramite un cortile di diversa pianta verso un’esedra o un porticato aperto e infine continua in rettilineo percorrendo il viale: il primo tipo di giardino è formato da un viale rettilineo che parte dall’esedra e finisce sul mare, nella maggior parte dei casi confluendo in chioschi, coffehouse, scalee che scendono a mare, belvederi, approdi, bagni e così via; il secondo tipo di giardino prevede un viale rettilineo che parte dal cortile e giunge fino a un piccolo ninfeo o esedra, decorati di solito da statue di divinità o di stampo rurale, e coronati spesso da rappresentazioni sacre che raffigurano San Gennaro, statua presente quale protezione dalle eruzioni, visto il prolungarsi del giardino verso il Vesuvio e la campagna circostante. In vari casi i giardini hanno dei parterre fioriti, delimitati da siepi, alla francese, come nel caso di Villa Vannucchi a San Giorgio a Cremano o di Villa Pignatelli di Monteleone a Barra, ma oggi sono presenti, nella maggior parte dei casi, giardini all’inglese formati da viali curvilinei, aiuole con alberi d’alto fusto ed essenze floreali pregiate come camelie, elementi quali cascate, ruscelli e laghetti, architetture pittoresche rappresentanti false rovine, torri, tempietti classicheggianti, pagode o chalet svizzeri che convivono accanto a residuali componenti tardo-barocche, tra cui chioschi con decori e forme rocaille, fontane con scogli in schiuma di lava, panchine con volute rococò. Numerose sono le statue e le fontane, che non risultano mai eccessivamente impattanti, ma in armonia completa rispetto al giardino e all’ambiente. Non mancano essenze mediterranee, come agrumeti, frutteti e vigneti che calano il tutto nel paesaggio rurale vesuviano.
Purtroppo molte di queste ville versano in condizioni precarie, quasi tutte non dispongono più delle ricchissime raccolte d’arte, dei sontuosi arredi e delle magnifiche suppellettili un tempo presenti al loro interno (alcune
sono state spostate nei musei napoletani), diverse riportano ancora le eleganti decorazioni e i luminosi affreschi interni, alcune hanno ancora i giardini.
VILLA LETIZIA
 Tale villa, appartenuta un tempo alle famiglie Cantalupo e Nasti, e ubicata lungo l’antica Strada di Santa Maria del Pozzo, ha una configurazione prettamente ottocentesca che si distacca alquanto da quella originaria. L’edificio in pianta è inserito in un quadrato e si sviluppa a doppia L, inoltre il fronte maggiore è più profondo dei bracci laterali e al piano terreno ha un grande ingresso che conduce al vestibolo dal quale si scorge l’arco trionfale di fondo. Una scala perpendicolare conduce a un grande ambiente con balcone sporgente verso il cortile e la campagna. Due grandi terrazzi fiancheggiano il corpo centrale che si eleva per tre piani, mentre gli altri per un solo piano. Il piano terra e il piano nobile, caratterizzati dal bugnato liscio, sono settecenteschi. Anche l’articolazione volumetrica, il gioco dei pieni e dei vuoti, le terrazze laterali, le cornici e le balaustre dei primi piani documentano una fase precedente a quella ottocentesca. Di particolare rilevanza è soprattutto l’arco che si apre alla fine del cortile, sopraelevato su una gradinata che dona una maggiore spinta scenografica all’architettura. I bracci laterali in pietra rustica caratterizzati da ornie aperte su finestre e balconi, chiusi da balaustre identiche a quelle dei terrazzi, sono invece rimaneggiamenti ottocenteschi. Sempre a epoca successiva si rifanno le sopraelevazioni in stile medievaleggiante, dai torrioni ospitanti delle scale a chiocciola alla merlatura superiore dei corpi laterali. Il parco fu realizzato negli anni Duemila, ma purtroppo è caduto nel degrado nel giro di poco tempo: è formato da un viale principale colorato da jacarande e bordato da siepi di spirea rossa alternata a spirea bianca, ed è arricchito da una flora molto varia formata da albizie, ippocastani, catalpe, ficus australiani e palme; si ammira anche un giardino all’italiana visibile nei pressi della villa, giardino costituito da un parterre valorizzato da piante di bosso e rose; sono presenti anche vari spazi per la socializzazione, quali una pista di pattinaggio, un’arena per le rappresentazioni e un’area giochi, ma versano tutti in pessime condizioni.
Tale villa, appartenuta un tempo alle famiglie Cantalupo e Nasti, e ubicata lungo l’antica Strada di Santa Maria del Pozzo, ha una configurazione prettamente ottocentesca che si distacca alquanto da quella originaria. L’edificio in pianta è inserito in un quadrato e si sviluppa a doppia L, inoltre il fronte maggiore è più profondo dei bracci laterali e al piano terreno ha un grande ingresso che conduce al vestibolo dal quale si scorge l’arco trionfale di fondo. Una scala perpendicolare conduce a un grande ambiente con balcone sporgente verso il cortile e la campagna. Due grandi terrazzi fiancheggiano il corpo centrale che si eleva per tre piani, mentre gli altri per un solo piano. Il piano terra e il piano nobile, caratterizzati dal bugnato liscio, sono settecenteschi. Anche l’articolazione volumetrica, il gioco dei pieni e dei vuoti, le terrazze laterali, le cornici e le balaustre dei primi piani documentano una fase precedente a quella ottocentesca. Di particolare rilevanza è soprattutto l’arco che si apre alla fine del cortile, sopraelevato su una gradinata che dona una maggiore spinta scenografica all’architettura. I bracci laterali in pietra rustica caratterizzati da ornie aperte su finestre e balconi, chiusi da balaustre identiche a quelle dei terrazzi, sono invece rimaneggiamenti ottocenteschi. Sempre a epoca successiva si rifanno le sopraelevazioni in stile medievaleggiante, dai torrioni ospitanti delle scale a chiocciola alla merlatura superiore dei corpi laterali. Il parco fu realizzato negli anni Duemila, ma purtroppo è caduto nel degrado nel giro di poco tempo: è formato da un viale principale colorato da jacarande e bordato da siepi di spirea rossa alternata a spirea bianca, ed è arricchito da una flora molto varia formata da albizie, ippocastani, catalpe, ficus australiani e palme; si ammira anche un giardino all’italiana visibile nei pressi della villa, giardino costituito da un parterre valorizzato da piante di bosso e rose; sono presenti anche vari spazi per la socializzazione, quali una pista di pattinaggio, un’arena per le rappresentazioni e un’area giochi, ma versano tutti in pessime condizioni.
VILLA BISIGNANO
 La villa, in un primo momento appartenuta ai Carafa di Maddaloni, venne ampliata nella prima metà del XVII secolo dal banchiere fiammingo Gaspare Roomer, che all’interno dell’edificio formò una delle più importanti raccolte d’arte dell’epoca: le sale della villa in pochi anni raccolsero dipinti di Leonard Bramer, Giacinto Brandi, Borgognone, Jan Boeckhorst, Gerard van der Bos, Jan Brueghel il Vecchio, Paul Bril, Battistello, Castiglione, Viviano Codazzi, Jacques Duyvelant, Aniello Falcone, Luca Giordano, Guercino, David de Haen, Pieter van Laer, Jan Miel, Cornelis van Poelenburgh, Cornelis Schut, Goffredo Wals, Bartolomeo Passante, Mattia Preti, Ribera (Sileno ebbro al Museo Nazionale di Capodimonte), Rubens (Banchetto di Erode alla Scottish Nation Gallery di Edimburgo), Andrea Sacchi, Carlo Saraceni, Massimo Stanzione, Van Dyck, Simon Vouet e Pieter De Witte. Dell’antico splendore sono rimasti gli affreschi dell’antica biblioteca della villa, realizzati da Aniello Falcone nel 1647 e rappresentanti: Battaglia tra Israeliti ed Amalachiti, Attraversamento del Mar Rosso, Adorazione del serpente di bronzo, Mosè fa scaturire l’acqua dalla rupe e Ritrovamento di
La villa, in un primo momento appartenuta ai Carafa di Maddaloni, venne ampliata nella prima metà del XVII secolo dal banchiere fiammingo Gaspare Roomer, che all’interno dell’edificio formò una delle più importanti raccolte d’arte dell’epoca: le sale della villa in pochi anni raccolsero dipinti di Leonard Bramer, Giacinto Brandi, Borgognone, Jan Boeckhorst, Gerard van der Bos, Jan Brueghel il Vecchio, Paul Bril, Battistello, Castiglione, Viviano Codazzi, Jacques Duyvelant, Aniello Falcone, Luca Giordano, Guercino, David de Haen, Pieter van Laer, Jan Miel, Cornelis van Poelenburgh, Cornelis Schut, Goffredo Wals, Bartolomeo Passante, Mattia Preti, Ribera (Sileno ebbro al Museo Nazionale di Capodimonte), Rubens (Banchetto di Erode alla Scottish Nation Gallery di Edimburgo), Andrea Sacchi, Carlo Saraceni, Massimo Stanzione, Van Dyck, Simon Vouet e Pieter De Witte. Dell’antico splendore sono rimasti gli affreschi dell’antica biblioteca della villa, realizzati da Aniello Falcone nel 1647 e rappresentanti: Battaglia tra Israeliti ed Amalachiti, Attraversamento del Mar Rosso, Adorazione del serpente di bronzo, Mosè fa scaturire l’acqua dalla rupe e Ritrovamento di
Mosè. Nel 1776 l’edificio passò ai Sanseverino di Bisignano Chiaromonte e venne integralmente ricostruito. La pianta del blocco principale è rettangolare, mentre la facciata principale è su uno dei lati minori, perpendicolare alla strada che porta alle “pigne del Solimena”, e si prolunga in un corpo basso che configura un cortile rustico laterale. Il cortile interno, che probabilmente ospitava feste e spettacoli teatrali, è rettangolare, è circondato da un portico e sul fondo, tramite tre archi, si apriva sul giardino ora non più esistente. I lati maggiori sono scanditi da cinque arcate e la terrazza a doppia L poggia sul porticato, così da costituire un belvedere continuo con due lati verso l’interno e quello di fondo aperto verso il giardino. Il lato interno del cortile ha un arco centrale serrato tra paraste e affiancato da archi a sesto ribassato la cui altezza coincide all’altezza di imposta dell’arco maggiore. La superficie tra imposta e cornice che sovrasta l’arco maggiore reca all’interno due grandi occhi ovali che accentuano il gioco tra vuoti e pieni. Attraverso una scala aperta a tre rampanti si giunge alla loggia del piano nobile, formata da tre fornici ripetuti, per l’esattezza quello centrale a sesto ribassato e i due laterali a pieno sesto a tutta altezza. Il piano nobile ha poi tre larghi balconi delimitati da belle cornici, mentre le aperture del vano scala recano balaustre in piperno di pregevole fattura. I rimaneggiamenti dovuti a Pietro Antonio Sanseverino accrebbero la superficie coperta tramite l’utilizzo di corpi sopraelevati. Di origine secentesca sono gli arconi ciechi esterni, le cornici, le ornie, le decorazioni, le balaustre e il cortile, mentre il rifacimento settecentesco si può constatare sulla facciata principale, caratterizzata da un bugnato liscio al piano terra e da balconate nei due piani superiori. La torre è parte dell’impianto primitivo, ed è coronata da una merlatura aggiunta nell’Ottocento. Caratteristiche sono le balaustre con figure che rappresentano gobbi, iconografia fiamminga che fa anche parte della tradizione napoletana, quale elemento apotropaico. I due fuochi ideali dell’edificio sono lo spazio interno del cortile tra loggia centrale e terrazza belvedere e lo spazio aperto che dalla terrazza un tempo dilatava per il lungo viale del giardino per arrivare al Vesuvio, fulcro del cannocchiale visivo. Il giardino, purtroppo andato distrutto negli anni del boom edilizio, era ricco di piante ed essenze pregiate, un orto botanico in miniatura che, data la sua importanza, fu studiato e schedato da Michele Tenore nel 1805 e nel 1809.
VILLA DE GREGORIO
 L’edificio, un tempo intitolato “villa e delizie di Sannicandro”, era isolato lungo il pendio che va da Villa Pignatelli di Monteleone alla Strada Regia. Non rimane molto dell’antico impianto architettonico, visibile nella pianta del Duca di Noja, in quanto nel 1866 la villa venne ampliata e arricchita da nuova decorazione realizzata da Nicola Breglia. Anche l’elegante emiciclo decorato da sculture che è oggi visibile davanti alla facciata è un’aggiunta tardo settecentesca che al tempo della realizzazione della mappa non era ancora presente. Di contro il giardino, tra i più integri tra quelli del Miglio d’oro, rispecchia nelle direttrici generali la primitiva sistemazione: un viale centrale si biforca a partire da un’aiuola ellittica, quindi si incrocia con un vialetto trasversale all’altezza di una vasca circolare in marmo, ubicata in un largo ottagonale delimitato da quattro panche in marmo adornate da spalliere in piperno di stile barocco; il viale termina infine in un larghetto decorato da una fontana, mentre dietro, sul poggio, è presente un fitto boschetto ravvivato da resti di elementi architettonici. E’ presente anche una bella serra in ferro e vetro, realizzata presumibilmente durante il restauro ottocentesco, che si segnala per il piccolo belvedere alla sommità della copertura. Di epoca ottocentesca sono
L’edificio, un tempo intitolato “villa e delizie di Sannicandro”, era isolato lungo il pendio che va da Villa Pignatelli di Monteleone alla Strada Regia. Non rimane molto dell’antico impianto architettonico, visibile nella pianta del Duca di Noja, in quanto nel 1866 la villa venne ampliata e arricchita da nuova decorazione realizzata da Nicola Breglia. Anche l’elegante emiciclo decorato da sculture che è oggi visibile davanti alla facciata è un’aggiunta tardo settecentesca che al tempo della realizzazione della mappa non era ancora presente. Di contro il giardino, tra i più integri tra quelli del Miglio d’oro, rispecchia nelle direttrici generali la primitiva sistemazione: un viale centrale si biforca a partire da un’aiuola ellittica, quindi si incrocia con un vialetto trasversale all’altezza di una vasca circolare in marmo, ubicata in un largo ottagonale delimitato da quattro panche in marmo adornate da spalliere in piperno di stile barocco; il viale termina infine in un larghetto decorato da una fontana, mentre dietro, sul poggio, è presente un fitto boschetto ravvivato da resti di elementi architettonici. E’ presente anche una bella serra in ferro e vetro, realizzata presumibilmente durante il restauro ottocentesco, che si segnala per il piccolo belvedere alla sommità della copertura. Di epoca ottocentesca sono
anche i belvederi e i terrazzi che ravvivano l’edificio, così come i bellissimi ambienti interni realizzati in stile (salottino alla turca, soffitto a specchi della sala da gioco, sala maiolicata a piano terra, salone affrescato con scene galanti al piano nobile). Anche la facciata è stata rifatta, ma la precedente configurazione non è stata stravolta, come si può ammirare nel disegno con scritta “Facciata principale del Casino dell’Eccellentissimo Signor Principe di S. Nicandro sito nel Casale della Barra”, attribuito al Vanvitelli: presenta tre ordini, il primo caratterizzato da un alto zoccolo ornato da un bugnato, mentre il secondo e terzo ordine sono collegati da lesene giganti che sorreggono il cornicione concluso da fastigio con stemma e balaustra; le finestre con balconi sono decorate da timpani triangolari e sono incassate in grandi nicchie intervallate da lesene; nicchie, lesene e timpani sono aggiunte ottocentesche.
VILLA AMALIA
La villa, risalente agli inizi del XVII secolo, ha una facciata percorsa da una cornice continua in piperno e si segnala per due elementi architettonico di raro pregio, ovvero il portale di gusto manierista e le finestre della scala. Il portale ha un fornice a tutto sesto ubicato tra paraste e sormontato da timpano spezzato nel quale è inserito un balcone con timpano. La cornice taglia le paraste del portale e ha il ruolo di raccordo tra portale e facciata. L’elegante scala aperta verso la strada e verso il cortile nei livelli più alti diventa un belvedere. La villa ha un andamento a L, che si evidenzia per l’ala che fiancheggia il cortile, formante due terrazzi digradanti. Il cortile irregolare, aperto su due lati verso la campagna, riporta interessanti tracce dei depositi rustici che fiancheggiavano l’accesso alla proprietà.
VILLA FILOMENA
La villa si trova all’incrocio tra la “via che porta alle pigne del Solimena” e quella che fiancheggia il Convento di San Domenico e si sviluppa per tre lati attorno a un cortile sul fondo del quale si apre l’accesso al parco, fiancheggiato da pilastri bugnati coronati da cuspidi piramidali. Il parco era costituito da un viale rettilineo che purtroppo è andato distrutto. La facciata è costituita da due piani sovrapposti e uno terreno, è molto semplice e si caratterizza per la semplice successione di aperture ripetute con un ordine insolito di cinque finestre centrali e due balconi agli estremi. Il prospetto si segnala infine per l’inclinazione della parete esterna nella parte basamentale che in alcune parti si interrompe e diventa contrafforte a scarpa.
VILLA PIGNATELLI DI MONTELEONE
 Iniziata nel 1728 dal Duca Diego Pignatelli, la villa è attribuita a Ferdinando Sanfelice, autore peraltro di Palazzo Pignatelli di Monteleone a Napoli, ultimato nel 1726. Si segnala il portale in spezzate a tre segmenti e bugne a punta di diamante, che è molto somigliante a quello napoletano, così da testimoniare un legame stilistico tra i due edifici. I lavori si prolungarono a lungo fino al 1766 e sono documentati anche diversi interventi da parte del Fuga. Molto particolare è senz’altro il corpo di fabbrica che chiude verso il giardino il cortile centrale: arretrato rispetto alla strada, si articolava secondo un corpo centrale, costituito da un’ambiente esagonale allungato, e ali simmetriche rettangolari arretrate suddivise in vari ambienti e terminanti in un locale a pianta quadrata arretrato e raccordato con un triangolo in cui è inserita una scala a chiocciola. Fuga accrebbe
Iniziata nel 1728 dal Duca Diego Pignatelli, la villa è attribuita a Ferdinando Sanfelice, autore peraltro di Palazzo Pignatelli di Monteleone a Napoli, ultimato nel 1726. Si segnala il portale in spezzate a tre segmenti e bugne a punta di diamante, che è molto somigliante a quello napoletano, così da testimoniare un legame stilistico tra i due edifici. I lavori si prolungarono a lungo fino al 1766 e sono documentati anche diversi interventi da parte del Fuga. Molto particolare è senz’altro il corpo di fabbrica che chiude verso il giardino il cortile centrale: arretrato rispetto alla strada, si articolava secondo un corpo centrale, costituito da un’ambiente esagonale allungato, e ali simmetriche rettangolari arretrate suddivise in vari ambienti e terminanti in un locale a pianta quadrata arretrato e raccordato con un triangolo in cui è inserita una scala a chiocciola. Fuga accrebbe
l’edificio di due piani ulteriori e realizzò una piccola costruzione come ingresso al nucleo originario, così che, raccordandola ad esso, il cortile veniva tripartito e la villa spostata sulla strada. L’esterno è totalmente privo di decorazione, eventualità dovuta probabilmente al fatto che i lavori non vennero mai conclusi, mentre degno di nota è l’androne a pianta ellittica con volta lunettata e fornice dilatato tramite ampio arco a sesto ribassato sostenuto da imponenti colonne su alto zoccolo, staccate dalla muratura, e scale con volte a padiglioni che concludono i vani, decorate da stelle di stucco. Nel fronte posteriore sul lato sinistro c’è un portico a sei arcate. Il parco, uno dei più grandi del Miglio d’oro, è ancora presente, è in condizioni pessime, ma sono presenti vari elementi di pregio: il “cafehouse” con padiglione a pianta quadrata, a due piani, con cupoletta su tamburo ottagonale, concludente la lunga prospettiva del viale principale, e due padiglioni minori simmetrici, tutte costruzioni decorate a rocaille.
VILLA SALVETTI
Nella mappa del Duca di Noja la villa è indicata accanto alla “strada che porta al casale della Barra” e oggi si configura come un corpo di fabbrica che costeggia la strada e prolungato verso l’interno con una configurazione ad U che delimita su tre lati un cortile chiuso sul fondo da un setto murario confinante con altre proprietà. Sulla mappa è possibile osservare anche il giardino, ubicato sul lato destro dell’edificio. La posizione dell’androne si trova ad avere sacrificata la simmetria rispetto ai corpi contrapposti, per dare maggiore risalto alla scala aperta sul cortile. Al giardino laterale si accede tramite la strada e tramite un corpo di fabbrica che fiancheggia il cortile. La facciata che guarda la strada reca riquadrature in stucco che circondano le varie aperture.
VILLA SPINELLI DI SCALEA
Il palazzo, appartenuto dapprima a Francesco Pignatelli conte d’Acerra e poi passato agli Spinelli, si sviluppa intorno a due cortili comunicanti tramite una doppia arcata: il primo cortile, di tipo patronale, a cui si accede tramite vestibolo strombato che indirizza la prospettiva verso il parco, termina in tre arcate che aprono sull’area verde; il secondo cortile, a cui si accedeva dalla strada attraverso un vestibolo più sobrio, è chiuso su tre lati e separato dal giardino da un corpo di fabbrica basso sormontato da un terrazzo, ed è uno spazio di servizio, preposto alla sosta di carrozze e a per necessità varie. I due cortili sono quindi impostati su due differenti tipologia, ovvero l’asse prospettico vestibolo-arcate-parco, l’altro intorno al cortile di servizio, mentre un doppio arcone sormontato da terrazzo fa da fusione tra i due nuclei abitativi. Il parco è stato modificato nel corso dell’Ottocento e si configura secondo una tipologia all’inglese: è caratterizzato da un tracciato tortuoso ed è ulteriormente valorizzato dalla presenza di una palazzina neoclassica e di una cappella neogotica.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Roberto Pane, Ville vesuviane del Settecento, Napoli 1959.
Cesare De Seta, Leonardo Di Mauro, Maria Perone, Ville vesuviane, Milano 1980.
Vittorio Gleijeses, Ville e palazzi vesuviani, Napoli 1980.
Sergio Brancaccio, L’ambiente delle ville vesuviane, Napoli 1983.
Vittorio Gleijeses, Le regali delizie in terra vesuviana, Napoli 1992.
Luigi Picone, I giardini delle ville vesuviane, Napoli 1998.
Pietro Lezzi, Per le ville vesuviane, Capri 2000.
Celeste Fidora, Sergio Attanasio, Ville e delizie vesuviane del ‘700: passeggiata da Napoli a Torre del Greco, Napoli 2004.
Percorsi vesuviani: architettura e paesaggio, Napoli 2005.
Filippo Barbera, Cultura e scienza nei giardini delle ville vesuviane, Portici 2007.